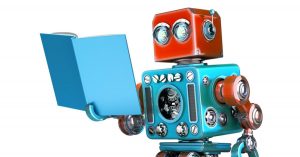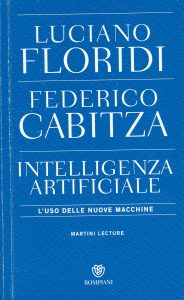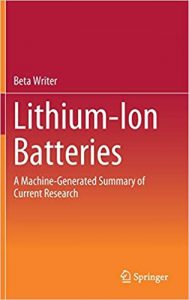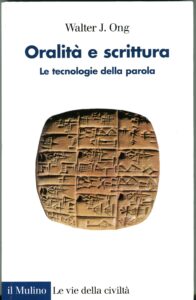 Nel susseguirsi delle invenzioni tecnologiche che hanno cambiato il mondo, la scrittura è l’evento storico fondamentale, ma per essere capito in pieno è necessario studiarlo mettendolo a confronto con il mondo culturale che lo ha preceduto: quello dell’oralità. È questa la tesi centrale di Oralità e scrittura, le tecnologie della parola dell’antropologo, filosofo, esperto in problemi della comunicazione, Walter Ong. Ripubblicato recentemente dopo la prima edizione uscita nel 1982.
Nel susseguirsi delle invenzioni tecnologiche che hanno cambiato il mondo, la scrittura è l’evento storico fondamentale, ma per essere capito in pieno è necessario studiarlo mettendolo a confronto con il mondo culturale che lo ha preceduto: quello dell’oralità. È questa la tesi centrale di Oralità e scrittura, le tecnologie della parola dell’antropologo, filosofo, esperto in problemi della comunicazione, Walter Ong. Ripubblicato recentemente dopo la prima edizione uscita nel 1982.
Il libro, malgrado i suoi oltre quarant’anni di età e il fatto che si occupi di tecnologie della comunicazione, non solo non risulta datato, ma è ancora considerato, nell’ambito degli studi di storia della cultura e comunicazione umana, un testo fondamentale. Questo è dovuto all’attualità della domanda che sottintende tutta la ricerca di Ong, vale a dire: quale impatto hanno avuto (e hanno) le tecnologie della comunicazione (parola, scrittura, stampa, computer) sul pensiero e sulla conoscenza degli esseri umani?
Per Ong il mondo dell’oralità, è stata una fase di esecuzioni verbali di grande bellezza e di alto valore artistico legate al senso dell’udito e al doppio filo della memoria. Ma è stato anche un mondo in cui mancava il pensiero astratto. Difatti, riprendendo il fondatore della neuropsicologia, il russo Aleksandr Romanovič Lurija, fa notare come una cultura orale non riesca a pensare in termini di figure geometriche, categorie astratte, logica formale ecc., tutte cose che derivano non semplicemente dal pensiero in sé ma dal pensiero condizionato dalla scrittura.
Ong indica un percorso evolutivo della psiche umana che solo con l’acquisizione della scrittura può sfruttare appieno le sue possibilità. Insomma, la scrittura è assolutamente necessaria per lo sviluppo della cultura: è indispensabile per la scienza, per la storia, per la filosofia, per la letteratura, per le arti e per il linguaggio stesso. È lo stesso Platone, “paradossalmente”, a dimostrarlo, sottolinea Ong, quando nel Fedro fa dire a Socrate che la scrittura è disumana poiché distrugge la memoria, indebolisce la mente…ma poi è proprio grazie alla scrittura che Platone può edificare il suo sistema filosofico basato sul pensiero astratto e le relative idee immutabili.
Il passaggio successivo, fondamentale, di Ong è quello di interpretare la scrittura come una “tecnologia”, cioè come un qualcosa di nuovo per il pensiero umano perché esterno alla semplice condizione fisica com’era invece l’oralità basata sul senso “intimo” dell’udito. Ora, il senso in gioco è quello “esterno” spaziale, della vista. E la scrittura con la sua “artificialità naturale” ha caratteristiche di una tecnologia perché richiede strumenti e perché attraverso questi strumenti realizza un oggetto fisico che prima non esisteva e che è distinto dalla persona che lo produce.
Ha rafforzare poi l’effetto che la scrittura ha sul pensiero e l’espressione, arriva la tecnologia della stampa che amplifica il carattere spaziale, visivo ed esterno rispetto alla fisicità umana in quanto oggettivato ancor di più dal processo tipografico. Ma, l’analisi di Ong non si ferma alla rivoluzione di Gutenberg, va avanti. E grazie anche alla collaborazione con il suo contemporaneo sociologo e studioso dei mezzi di comunicazione Marshall McLuhan, affronta anche i cambiamenti sul pensiero e conoscenza umana apportati dai nuovi media elettronici (radio, tv) e dai primi computer.
Condivide appieno il famoso slogan di McLuhan: “il medium è il messaggio”, nel senso che si trova d’accordo sul fatto che sia proprio il mezzo (medium) con cui la lingua è comunicata (voce, scrittura, stampa, media elettronici e digitali) a determinare l’organizzazione del pensiero. E proprio le ultime riflessioni di Ong sui nuovi media e sull’avvento dell’era dei computer, lasciano trasparire la sua convinzione nel ritenere la “parentesi di Gutenberg” – ovvero quel periodo di circa 500 anni situato tra le lunghe fasi della cultura orale e chirografica e la fase attuale dei media digitali – una sorta di “eccezione” all’interno del lunghissimo percorso del pensiero umano. Alla quale inevitabilmente seguirà l’affermarsi di una (nuova) oralità questa volta però supportata non solo dall’udito e dalla memoria ma soprattutto da tecnologie esterne, quelle dei media digitali, comunque anch’esse basate – come succedeva anche per l’oralità primaria – sull’istantaneità, la ridondanza e l’ubiquità.